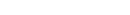San Giuseppe, Santo Frittellaro
 Nulla di irriguardoso nei confronti del buono e mite San Giuseppe, per carità, ma la fantasia popolare, si sa, non conosce confini e non di rado arriva tanto in alto che più in alto non si può.
Nulla di irriguardoso nei confronti del buono e mite San Giuseppe, per carità, ma la fantasia popolare, si sa, non conosce confini e non di rado arriva tanto in alto che più in alto non si può.
E lassù c’è anche san Giuseppe, molto amato dalla gente, anche assai presente anche nelle raffigurazioni pittoriche e tuttavia, nell’immaginario della gente, appare sempre un po’ defilato rispetto ai suoi colleghi del paradiso, quasi in disparte, umile e saggio, direi timido, e per questo molto amato dal popolo che lo ha eletto come protettore dei poveri.
La festa in suo onore, il 19 marzo, è stata sempre accompagnata da sobrie funzioni religiose seguite, però, da tutt’altro che sobrie feste mangerecce nelle strade e nelle piazze di tutto il Paese e ogni luogo ha le sue peculiarità ossia, tradotto in termini mangerecci, le sue specialità.
Oggi, occorre dirlo, la ricorrenza è stata molto ridimensionata nelle sue manifestazioni popolari, ma ha assunto un carattere più intimo e familiare e il 19 marzo si festeggia il papà, in onore e in ricordo di Giuseppe, papà di Gesù e, naturalmente, si festeggiano i vari Giuseppe e Giuseppa, nelle loro diverse e fantasiose declinazioni: Giuseppa Giuseppina, Peppina, Pina, Pinuccia, Peppinella e, al maschile: Peppino, Pino, Pinuccio, Peppinello, e così via.
Noi, però, qui vogliamo dare uno sguardo alla festa di San Giuseppe del passato per rievocare momenti della tradizione popolare che hanno lasciato memorabili ricordi nella mente e nel cuore della gente.
Non possiamo raccontare delle celebrazioni che avvenivano, e in parte ancora avvengono, in tutto il Paese, ma come non parlare delle mitiche frittelle e dei frittellari di Roma che a San Giuseppe celebravano il loro trionfo inondando la città di celestiali profumi di fritto? E come si fa a non fare almeno un accenno, un piccolissimo accenno, alla pasta cu meli, ai pupi i san Giuseppi, ai cannoli e alle cassate siciliane?
E allora andiamo!
A Roma, in passato, la festa si celebrava in molte chiese dedicate al Santo, ma quella più significativa aveva luogo nella chiesa di S: Giuseppe dei Falegnami, al Foro Romano, dove la Confraternita dei Falegnami organizzava i festeggiamenti invitando anche i rappresentanti di altre confraternite.
La festa, che si svolgeva all’aperto, era particolarmente vivace e movimentata ed il popolo accorreva numeroso da ogni angolo della città.
Dopo la parte religiosa, che comprendeva anche inni e cortei, la gente si accalcava nei pressi del Foro dove venivano allestite allegre bancarelle con frasche e lampioncini, mentre vivacissimi frittellari, con parannanza e cappellaccio alla bisogna, friggevano all’aperto le loro delizie dentro enormi padelloni che liberavano nell’aria soavi profumi che si espandevano per vicoli e piazze fino a lambire e ad intrufolarsi nelle austere stanze del potere politico e nei sacri palazzi d’oltre Tevere.
E neanche a dire che i frittellari lavorassero in silenzio perché spadellando spadellando parlavano e sparlavano senza sosta elogiando i loro meravigliosi prodotti ed arrivando persino ad inventare dei versi sulle loro sublimi creature gustose.
Zanazzo, cultore di tradizioni romane, parla di grandi festeggiamenti nel nascente quartiere Trionfale, all’inizio del novecento, e Checco Durante, l’indimenticato attore romano, nel 1950 scrisse dei versi dedicati a san Giuseppe che viene definito, appunto, Frittellaro.
San Giuseppe frittellaro O gran santo benedetto
Tanto bono e tanto caro Fa che ognuno ciabbia un tetto
Tu che sei così potente La lumaca affortunata
D’aiutà la pora gente Se lo porta sempre appresso
Tutti pieni de speranza Fa pe’ noi puro lo stesso.
Te spedimo quest’istanza Facce cresce sulla schina
Una cammera e cucina
Naturalmente durante la festa non c’erano solo i frittellari, ma anche i venditori di porchetta, di mostaccioli, di zucchero filato ecc. ed anche allora non mancavano nemmeno i mendicanti che per pochi soldini, offrivano le immaginette di S. Giuseppe con annessa preghiera.
Oggi la festa ha perso molto del carattere popolare dei suoi anni migliori, lo abbiamo detto, e si svolge in maniera meno eclatante e forse anche meno partecipata.
I tempi sono cambiati e con loro anche i gusti, tanto che i bignè, pur assai gustosi, hanno soppiantato le gloriose e saporitissime frittelle
E, a proposito di dolci, scendiamo giù in Sicilia a vedere cosa si fa all’ombra dell’Etna.
Valguarnera, in provincia di Enna, non è una delle località più conosciute della Sicilia, ma chi vi si reca in occasione della festa di san Giuseppe scoprirà lungo le strade e le piazze un’infinità di leccornie, collocate in forma di piramide a gradini che le famiglie del posto offrono ai poveri come ringraziamento a S. Giuseppe per grazia ricevuta.
E che leccornie!
Pasta cu meli (miele), pupi i San Giuseppi, cioè un pane che ha la forma degli strumenti di lavoro del falegname e, ancora, un trionfo di primi piatti, salsiccia profumatissima, formaggi vari dal gusto indimenticabile, broccoli e verdure d’ogni genere e poi, cannoli, cassate e cassatelle, babà e le immancabili arance di Sicilia.
A queste tavole partecipano le comparse che rappresentano San Giuseppe, la Madonna e Gesù, ma non mancano i santi Gioacchino e Anna e, a volte, anche gli Apostoli, in occasione di un miracolo vero o presunto.
Le tavolate di San Giuseppe vengono preparate in casa dei devoti e restano aperte tutto il giorno.
Questa usanza ricorda la Sacra Famiglia e lo spirito di carità cristiana verso i poveri.
La Cavalcata di San Giuseppe a Scicli ( Ragusa )
Il culto di S. Giuseppe è molto diffuso in Sicilia, lo dicevamo, ma non tutti sanno che il buon vecchio è anche protettore delle nubili, degli orfani e, soprattutto, dei poveri ed è per questo che in molte località, ma soprattutto a Scicli, la monumentale città barocca in provincia di Ragusa il cui centro storico è stato insignito dal titolo di Patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco, in occasione della festa, viene preparato un ricchissimo banchetto per i poveri.
La sera prima, cioè il 18 marzo, avviene la cavalcata di San Giuseppe, la cui tradizione risale al Medioevo e si confonde con il culto pagano che gli antichi contadini rivolgevano agli dei perché propiziassero buoni raccolti.
Dunque, la sera del 18 marzo, a Scicli, una spettacolare parata di cavalli con splendide bardature sfila per le vie della città tra due ali di folla plaudente e nella piazza su cui affaccia la chiesa parrocchiale vengono venduti all’asta i prodotti della terra, le primizie della primavera: gustosissime fave e piselli dolcissimi, i primi pomodori maturati al sole di Sicilia, poi, ancora, pane, ricotta, caciocavallo e salumi a volontà.
I cavalli vengono benedetti con cerimonia solenne e poi, con passo lento e cadenzato, seguono il corteo della Sacra Famiglia: Gesù, Giuseppe e Maria tutti e tre su un unico asino.
I cavalieri vestono secondo il costume locale: pantaloni e gilet di velluto scuro con lunga e variopinta fascia alla vita, camicia bianca con maniche rimboccate, berretto ( a burritta ) e, per finire, una pipa in bocca di creta o di canna.
Particolari sono le gualdrappe dei cavalli, intessute di fiori: le violacciocche dai colori che vanno dal rosso al viola, lavorate su disegni a tema, ad esempio la Sacra Famiglia, oppure lo stemma del Comune ecc.
La tessitura dei fiori si tramanda di padre in figlio e spesso è un segreto di famiglia.
Lungo il percorso della cavalcata vengono accesi dei falò e ognuno porta una fiaccola fatta con fascine di giunchi raccolti in agosto durante il novilunio, messi ad asciugare al sole e poi conservati nei fienili per la festa.