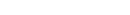Dalla primavera araba a Giulio Regeni: una democrazia che emerge a fatica
A cinque anni dalla primavere arabe, il sogno di una democrazia sembra ancora lontano. Forse perché il processo di cambiamento è più lungo del previsto, o forse perché – in casi come l’Egitto- la minaccia dei terroristi è troppo forte per non poter mantenere il pugno duro. Fatto sta che una ribellione contro i vecchi regimi c’è stata, solo che il risultato è stato diverso da quello che tutti si aspettavano.
Oggi questi paesi continuano a vivere tra guerre e atrocità. Cos’è che non ha funzionato? Lo Yemen era – ed è- in uno stato di latente guerra civile, oggi influenzata dallo scontro tra Iran e Arabia Saudita. Quest’ultima, poi, è intervenuta con il suo esercito – a favore della dinastia sunnita- anche nella ribellione in Bahrein, per stroncare il “complotto” della popolazione sciita. In Siria la situazione era estremamente complicata: la minoranza alawita (sciita), sostenitrice del regime quarantennale baathista, ha combattuto fino all’ultimo per mantenere il potere. E allo stesso tempo, il movimento non violento siriano è stato “sostituito” da una rivolta armata sostenuta da Turchia, Arabia Saudita e Stati Uniti; quindi ha potuto fare ben poco. Il caos di oggi ha portato poi questo paese a far parte dello Stato Islamico dell’ Isis e a divenire bersaglio di attacchi aerei e non. Da ultimo sono avvenuti numerosi bombardamenti da parte dei russi con obiettivi indiscriminati coinvolgendo numerosi civili e strutture pubbliche. Anche la Libia oggi, in uno stato di completa anarchia, apre la porta agli jihadisti e non si sa quale sarà la sua fine. Ed infine l’ Egitto, con una storia tutta sua, aveva in realtà visto la vittoria delle proteste non violente. Ma la minoranza laica, con la vittoria dei Fratelli musulmani alle elezioni del 2012, per paura ha sostenuto l’intervento militare e oggi l’esercito controlla nuovamente il paese.
Il regime autoritario di Abdel Fattah al Sisi non permette dissensi, giustifica la violenza sui cittadini nascondendosi dietro la parola “terrorismo” e arresta chi non è allineato. Una realtà impensabile e sconosciuta per noi, che pensavamo all’Egitto come uno dei paesi più “democratici” e occidentalizzati del mondo arabo. Fino a che non ci è giunta la notizia, il 3 febbraio, della morte del nostro connazionale Giulio Regeni, ricercatore di 28 anni. Giulio stava facendo degli studi sulle attività del sindacato egiziano per la Cambridge University a Oxford. All’origine della sua morte potrebbero esserci proprio le informazioni raccolte durante le sue ricerche sui sindacati, che sarebbero state intercettate dai servizi segreti egiziani. Come scrive Fiorenza Sarzanini, il ragazzo temeva per la sua incolumità, poiché si era accorto di essere stato fotografato mentre partecipava a un’assemblea sindacale. E’ evidente che le sue preoccupazioni avevano un fondamento. E’ morto il 25 gennaio al Cairo, con evidenti segni di tortura sul suo corpo. Aveva sette costole rotte, segni di scariche elettriche sui genitali e un’emorragia cerebrale, secondo i dettagli della perizia medica diffusi dalla Reuters. La sua morte, come confermato anche dalla seconda autopsia fatta in Italia, è stata causata dalla frattura di una vertebra in seguito a un colpo violento. Le indagini si stanno svolgendo contemporaneamente sia in Egitto sia in Italia; ma in Egitto procedono a rilento, probabilmente a causa della scarsa collaborazione delle autorità del Cairo. Nel frattempo gli investigatori italiani sono sempre più convinti del coinvolgimento degli apparati egiziani nella vicenda, anche se faticano a trovare nuovi elementi nella morte del ragazzo.
Se fosse così, se realmente Giulio fosse stato ucciso dai servizi segreti egiziani (o apparati istituzionali simili), ci sarebbe da fare delle grosse considerazioni. A partire dal forte richiamo, che personalmente vedo, alle torture subite dai dissidenti durante il regime militare argentino degli anni 70, fino a considerare un forte fallimento quello che le ribellioni del 2011 hanno portato. E noi (Europa e America) che ruolo abbiamo avuto in tutto questo? I nostri interventi militari sono sempre stati fatti in nome di “un’esportazione della democrazia”, eppure, quando realmente serviva, noi non c’eravamo. Abbiamo diffuso e appoggiato la primavera araba, li abbiamo silenziosamente aiutati a far cadere i loro regimi e poi li abbiamo lasciati allo sbaraglio, in balia del più forte. Ci permettiamo continuamente di intervenire in processi culturali che non sono nostri, cerchiamo di pilotarli, ma alla fine, al momento del reale bisogno, emerge che in realtà non sappiamo fare nulla di più di un intervento militare. Forse la democrazia, a livello culturale e non militare, non la sappiamo esportare davvero. E forse, se Giulio è morto, è anche un po’ colpa nostra.